

 Dino Virgili
Dino Virgili 

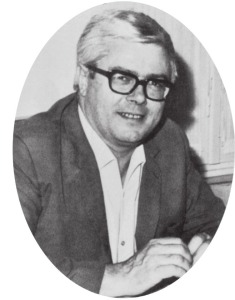
Questa immagine, 'Virgili Dino-1925-1983', è stata fornita da Dizionario biografico dei Friulani.
|
Il padre di Dino era Basilio Virgili e la madre era Elvira Palmino.
I nonni paterni si chiamavano Bernardo Virgili e Caterina Scrosoppi.
E' deceduto all'età di 58 anni il 16 Giugno 1983 a Udine.
Note Generali
da: DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI FRIULANI :
Nato a Ceresetto di Martignacco (Udine) nel 1925, frequentò, tra il 1937 e il 1941, l’Istituto tecnico Antonio Zanon, ma si diplomò presso l’Istituto magistrale Caterina Percoto, dove ebbe modo di conoscere (e di farsi conoscere da) Giuseppe Marchetti, docente d’eccezione. Il tirocinio era stato precoce nel perimetro ristretto, ma coeso, delle iniziative locali: «La vôs di Martignà», «Strapaese». Sarà poi intensa la collaborazione con «La Patrie dal Friûl», con le riviste della Società filologica friulana (dal 1967 al 1974 dirigerà «Sot la nape») e altre testate. Un impegno profuso anche in campo scolastico: maestro alla scuola Enrico Fruch, nella periferia di Udine, l’attività didattica di V. si allargò ai corsi di cultura friulana organizzati dalla Filologica. Consigliere comunale socialista a Martignacco, V. si spense a Udine nella notte del 16 giugno 1983. Decisivo per la sua vicenda è il 1949, l’anno di “Risultive”. Preceduta da una lunga gestazione sulle pagine di «La Patrie dal Friûl», “Risultive” si costituisce a Fagagna il 9 gennaio 1949 (il 13 febbraio assume, a Moruzzo, l’etichetta-emblema, forse dalla villotta «Aghe aghe risultive…» [Acqua acqua risorgiva…]). L’autonomia friulana, nella prospettiva di Marchetti, è l’idea-perno attorno a cui ruota anche l’istanza letteraria: «Motivo perciò a una decisa affermazione in campo italiano ed europeo della civiltà friulana è oggi la creazione di una condizione pari a quella che ne rese possibili le prime manifestazioni artistico-letterarie, cioè una larga autonomia regionale come atto d’autocoscienza. È l’unico fatto che possa salvare ancora il Friuli… Da questa rinascita della coscienza e quindi della civiltà friulana sboccerà una ‘letteratura nazionale’ (in quanto cosciente di sé e identificabile quindi con una manifestazione civile)». Respinto il «dialettalismo» di Zorutti, V. respinge anche la poetica pasoliniana perché per il friulano non sarebbe possibile «inserirsi nell’esperienza d’altrove senza travisare il suo carattere tipico», e prospetta una terza ipotesi: «La nostra tradizione va ricercata dentro di noi stessi, nella nostra essenza, nelle manifestazioni più pure e illese da qualsiasi influenza estranea, che sono l’esile filo che s’affonda alle origini e giunge fino a noi attraverso il tempo: cioè nella produzione popolare, dove il popolo anonimo esprime se stesso impersonalmente in ogni momento, nel pianto e nell’amore, nell’illusione e nell’ironia, istintivamente e perciò poeticamente». Dove sono palesi i risvolti neoromantici: il nesso nazione-popolo, un popolo che si esprime impersonalmente, istintivamente e perciò poeticamente. Il manifesto di “Risultive” «non impone limiti o programmi di scuola: invita soltanto a riascoltare, in continuità evolutiva, le suggestioni della terra e dell’anima friulana, risorgenti dalle radici native della stirpe e dalla preistoria poetica e narrativa popolare e a ricrearle, in innocenza e purezza, nella temperie della lirica e della prosa moderna e nella luce di una chiara coscienza e di un puntuale aggiornamento critico della cultura». Il richiamo al mondo popolare è un dato tipico dell’immediato dopoguerra, «innocenza e purezza» rinviano al mito romantico della creatività spontanea del popolo, pur se la costellazione semantica che individuano e la stessa terminologia sono altrimenti attive nel vocabolario del Pasolini di quegli anni. Una «letteratura tipicamente friulana» peraltro non è senza sottintesi polemici: uno scarto secco, una orgogliosa distanza rispetto ai sofisticati principi estetici della “Academiuta” casarsese. Scarto e distanza che Pasolini nega, con analoga intransigenza: «In questo bilancio fallimentare, tuttavia, un conto torna: e sono i versi di N.A. Cantarutti, A. Cantoni, e B. Virgili. Checché essi ne dicano, fanno parte del cerchio dell’Academiuta e io li annovero tra i felibri, data la loro giovanissima età, per la tecnica della loro lirica e per i sentimenti espressi pressappoco con lo stesso procedimento che ho descritto a proposito dei giovani poeti casarsesi». “Risultive” come filiazione, ramo minore dell’“Academiuta”. Ma “Risultive” ha programmi che non collimano con le scelte di Pasolini: un friulano non come lingua della (e per la) poesia, non varietà laterale e idioletto geloso, ma lingua a tutto campo, in una veste (di fatto la varietà centrale promossa a koinè) valida per l’intero dominio friulano e abilitata a tutti gli usi e a tutti i registri. V. si cimenta anche nella sfida del romanzo, un romanzo dalla trama sinuosa, densa di eventi e di figure, dettata da un entusiasmo febbrile e sostenuta da una competenza linguistica non comune. L’aghe dapît la cleve. Conte di amôr [Il corso d’acqua ai piedi del declivio. Racconto d’amore] è del 1949, ma la pubblicazione si avvia nel 1951 in «La Patrie dal Friûl», si interrompe nel 1954, per riprendere parzialmente nel 1955 in «Il Friuli» di Leone Comini. Il romanzo compare in volume nel 1957 e in seconda edizione, rivista, nel 1979. È la storia di una famiglia intrecciata con la storia di un intero paese. L’azione si svolge tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. I Batiston, gente fiera che abita ai bordi, non si piega al signorotto locale. Premuta dalle trasformazioni sociali, la famiglia rischia di disperdersi, ma un discendente, un nipote, si reinstalla alla fine nella vecchia casa a perpetuarvi la vita. ...
Postumo, ma già predisposto dall’autore, esce nel 1984 Paisanis. Elzevîrs e contis [Paesane. Elzeviri e racconti], per qualche aspetto incunabolo del romanzo, una scelta di brani che copre gli anni 1945-1965. A margine del volume Andreina Ciceri, che in L’aghe dapît la cleve aveva apprezzato lo «struggente lirismo», osserva che V. «realistico non è, perché non è un vero prosatore, ma un lirico, e le sue immagini non sono plastiche, ma pittoriche». Un laboratorio comunque di privilegio, che consente di sondare la scrittura di V.: dagli indugi assaporati sul paesaggio («Tal gno paîs, dapît la cleve, la cjase domenicâl cul morâr e il soreli su lis ramis, tal curtîl, e il zuc daûr cui ciprès in cuc, e la strade cui pôi su l’aghe, dilunc i roncs, si slàrgjn sun chê grande viarture dal plan…»...
(http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/virgili-dino/)
-
Albero Genealogico Ascendente
-
*Ci sono antenati di questa persona. Per i dettagli clicca sul nome


 - n. a Ceresetto di Martignacco
- n. a Ceresetto di Martignacco


 - n. 1802 a Ceresetto di Martignacco, m. 06 Feb 1878 a Ceresetto di Martignacco
- n. 1802 a Ceresetto di Martignacco, m. 06 Feb 1878 a Ceresetto di Martignacco





 - n. 1829 a Ceresetto di Martignacco
- n. 1829 a Ceresetto di Martignacco






 - n. 1802, m. 28 Apr 1872 a Ceresetto di Martignacco
- n. 1802, m. 28 Apr 1872 a Ceresetto di Martignacco




 - n. 25 Mag 1882 a Ceresetto di Martignacco, m. 04 Nov 1967 a Moruzzo (UD)
- n. 25 Mag 1882 a Ceresetto di Martignacco, m. 04 Nov 1967 a Moruzzo (UD)




 - n. 09 Set 1736 a Martignacco (UD)
- n. 09 Set 1736 a Martignacco (UD)



 - n. 17 Gen 1782 a Martignacco (UD), m. 03 Ott 1854 a Martignacco (UD)
- n. 17 Gen 1782 a Martignacco (UD), m. 03 Ott 1854 a Martignacco (UD)







 - n. 28 Set 1808 a Martignacco (UD), m. 09 Feb 1880 a Martignacco (UD)
- n. 28 Set 1808 a Martignacco (UD), m. 09 Feb 1880 a Martignacco (UD)



 - n. 1785
- n. 1785

 - n. 25 Lug 1845 a Martignacco (UD)
- n. 25 Lug 1845 a Martignacco (UD)


 - n. 1813 a Santa Margherita, Moruzzo (UD), m. 26 Ago 1868 a Martignacco (UD)
- n. 1813 a Santa Margherita, Moruzzo (UD), m. 26 Ago 1868 a Martignacco (UD)

- n. 1925 a Ceresetto di Martignacco, m. 16 Giu 1983 a Udine

-